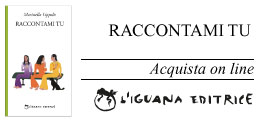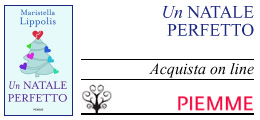Ginevra Amadio ha parlato di Donne che non muoiono su Treccani Magazine
È il corpo, con la sua carica sovversiva, il fuoco di due delle opere più intense pubblicate negli ultimi mesi del 2024: Electra di Violetta Bellocchio (il Saggiatore) e Donne che non muoiono di Maristella Lippolis (Vallecchi). Non si giudichi azzardato l’accostamento di testi solo apparentemente distanti sul piano strutturale, essendo il primo un lavoro anfibio – verrebbe da dire qualcosa di scritto – e l’altro un romanzo “puro”, tramato di una lingua poderosa e organizzato per piani complessi, intrecciati, ma lineari. Il punto di convergenza sta nel potere della parola con cui le due autrici mettono in scena il tentativo di costruire una geografia personale fondata su un duro apprendistato alla vita pubblica e privata.
Da un lato l’auto-sdoppiamento di Bellocchio, che per raccontare sé stessa diventa un’altra, Barbara Genova, e poi ritorna Violetta, con tutto il suo carico di sofferenze, disincanto e sbagli; dall’altro l’occhio indagatore di Lippolis, benevolo e tagliante al tempo, che scava nel vissuto di dodici donne in disequilibrio tra lavoro e quotidianità, segnate da abusi variamente declinati, rielaborati per il tramite della lettura e dunque attraverso la scrittura altrui, strumento salvifico e interrogante. (……………………………………………………………………………….)
Non diversamente, nel romanzo di Maristella Lippolis, le donne costrette a fare i conti con l’abuso si trovano strette nell’imbuto dell’inadeguatezza, della responsabilità distorta e tragica di sentirsi in fondo complici, inidonee al proprio ruolo. Così Romina, che dinnanzi al marito, le cui mani «da un momento all’altro possono trasformarsi in armi contro di lei» abbassa lo sguardo e pensa: Forse stai sbagliando, non hai ancora imparato come difenderti e ti comporti come se già lo sapessi fare. Lo stai provocando, proprio come Melania ti ha raccomandato di non fare. […]. Chiedigli scusa. Chiamalo! Così se avesse deciso di restare nei paraggi e sorprenderti, sentirai squillare il suo cellulare. […] Romina! La tua voce non è abbastanza contrita, anzi, nasconde persino un filo di ironia (pp. 51, 52).
Se l’opera di Bellocchio si configura, tuttavia, come il referto di una sparizione, la cancellazione di un corpo violato dall’aggressione fisica e dallo sguardo altrui, in un mondo – quello editoriale – che fa del personal branding un imperativo amorale, Donne che non muoiono rievoca già dal titolo l’idea di gettarsi nella lotta, di fare dell’esperienza comune un terreno di ripartenza esibita. Le protagoniste, che si riuniscono nella libreria di una di loro, Alice, per leggere storie di coraggio e di vendetta, trovano nelle parole di altre donne la forza di ribellarsi, di assumere un punto di vista diverso, e in fondo tutto da costruire. Il romanzo – che è anche una miniera cui attingere per arricchire il proprio bagaglio di letture – fotografa dunque il linguaggio come luogo cruciale di un problema più esteso: quello del rapporto delle donne con la società, con la cultura, con un uso subalterno della parola che implica, anche, un suo rifiuto distruttivo. La polifonia che si fa condivisione – e dunque strumento d’azione –, permette così di leggere la parola come unico spazio in cui avanzare dubbi, far emergere l’esperienza e dunque correggerla, immaginarla in prospettiva. Così la lingua diversa, ma parimenti anti-retorica di Bellocchio e Lippolis, restituisce il senso di un discorso complesso, in cui corpo, parola e immagine si sommano, si mischiano, e alla scrittura si arriva per strappi, così come alla parola, per raccontare qualcosa di sé, per dar voce alle altre e una nuova forma al silenzio e al rumore: Là fuori pietre rotolano nel buio, fanno rumore. Energia che si accumula, terra che viene trascinata e rotola senza più potersi fermare. Apriranno voragini, cambieranno gli orizzonti. Si apriranno vie di fuga e di salvezze. Potrebbe accadere. Accadrà (Donne che non muoiono, p. 304).
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata